Emma De Angelis – Caporedattore
Alessia Greco – Editor
Maria Russo – Redattore ordinario
Renato Gatti – Giornalista
Spartaco Pascucci – Editorialista
Piazzale Luciano Anceschi, 5, 40141 Bologna BO, Italy
[email protected]





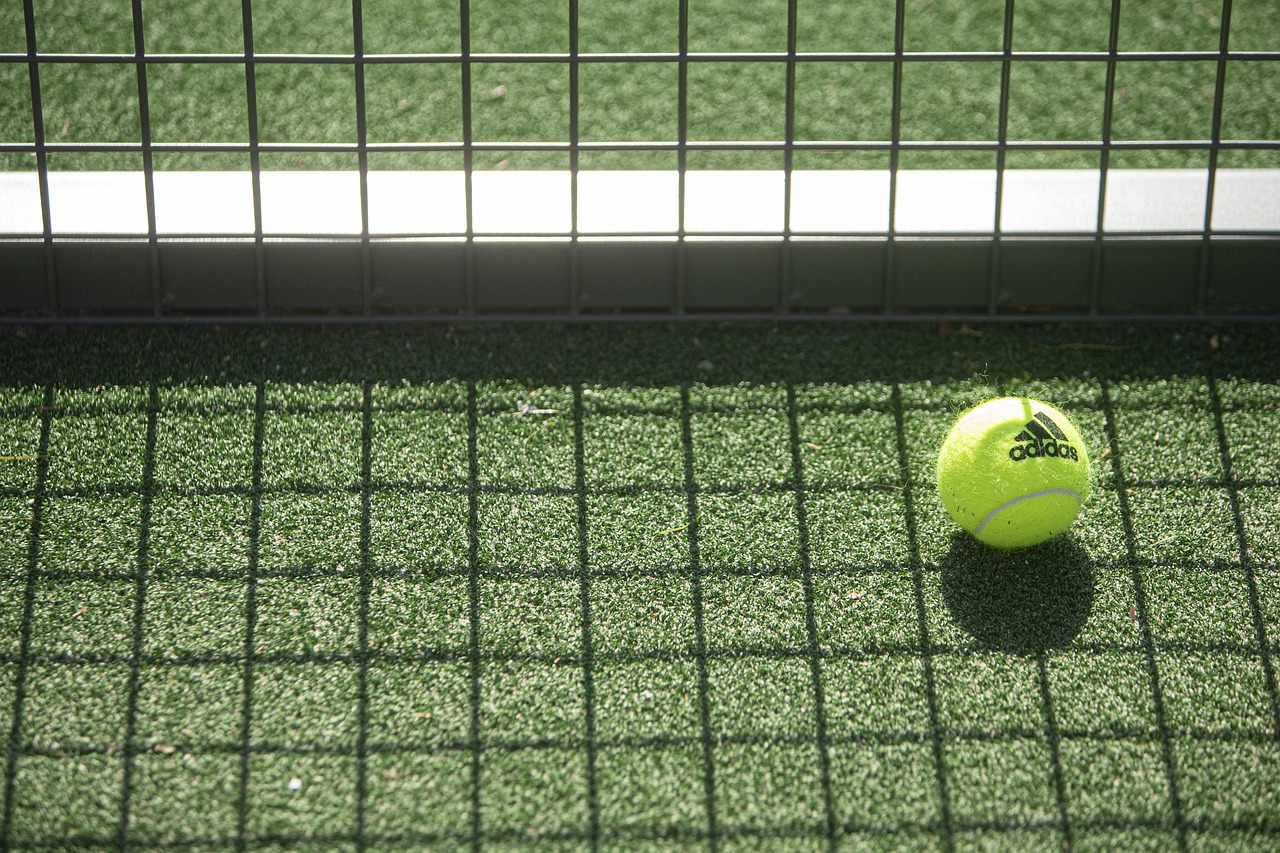




Emma De Angelis – Caporedattore
Alessia Greco – Editor
Maria Russo – Redattore ordinario
Renato Gatti – Giornalista
Spartaco Pascucci – Editorialista
Piazzale Luciano Anceschi, 5, 40141 Bologna BO, Italy
[email protected]