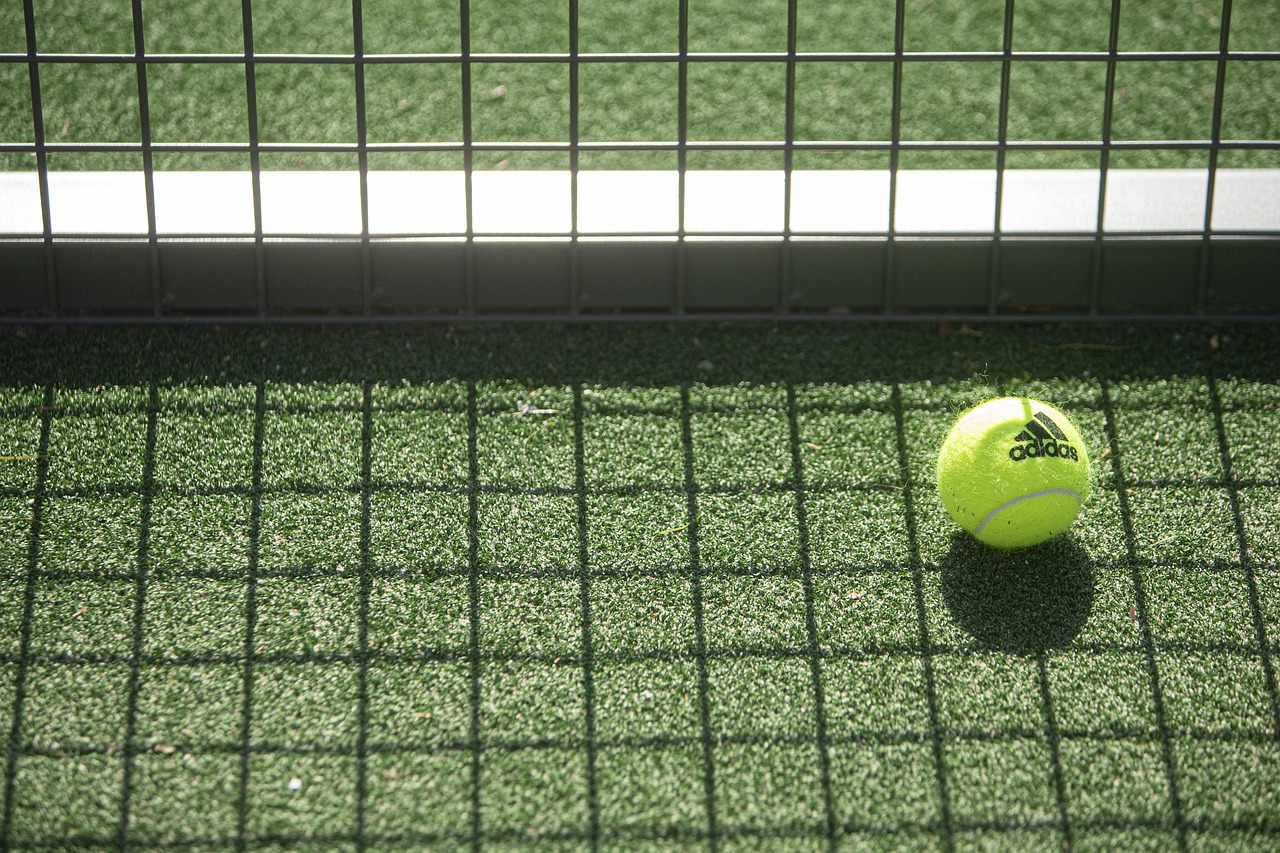Chipolo POP: l’alternativa più rumorosa agli AirTag, compatibile con Android e iPhone
I dispositivi di localizzazione come gli Apple AirTag hanno rivoluzionato la mia vita quotidiana. Non è un’esagerazione: mi hanno letteralmente fatto risparmiare ore di stress e frustrazione nel cercare oggetti sparsi per casa. Certo, se avessi seguito il consiglio di mio nonno — “ogni cosa al suo posto” — forse non ne avrei avuto bisogno. Ma la realtà è ben diversa (scusami, nonno!).
Ora che il mercato dei tag di localizzazione si è aperto anche ai produttori terzi, stiamo assistendo a un’ondata di innovazione. Un’azienda che ha attirato particolarmente la mia attenzione è la slovena Chipolo. Ho provato diversi modelli dei loro dispositivi, li ho recensiti e utilizzati a lungo: non mi hanno mai deluso.
L’ultima novità di Chipolo si chiama POP, una linea di tag intelligenti che offre compatibilità sia con la rete Find My di Apple sia con la rete Find My Device di Google. In pratica, ciò significa che questi dispositivi possono essere localizzati ovunque nel mondo, indipendentemente dallo smartphone che si utilizza.
Ogni Chipolo POP ha un raggio d’azione Bluetooth di 90 metri (circa 300 piedi), più che sufficiente per la maggior parte degli ambienti domestici o lavorativi. I tag sono disponibili in diversi colori vivaci — blu, nero, verde, rosso, bianco e giallo — permettendo così di abbinarli agli accessori personali o di distinguerli facilmente.
Ma il vero punto di forza del Chipolo POP è il volume del suo segnale acustico: ben 120 decibel. Per fare un confronto, è il livello sonoro di un tuono, di un concerto rock o di uno spettacolo pirotecnico. Questo rende il POP particolarmente efficace quando si devono ritrovare oggetti smarriti, come un mazzo di chiavi finito tra i cuscini del divano.
L’alimentazione è garantita da una batteria CR2032, facilmente sostituibile dall’utente, con una durata stimata di circa un anno. Un dettaglio che aggiunge praticità e autonomia al prodotto, senza costringere a ricorrere frequentemente a ricariche o sostituzioni complesse.
In sintesi, Chipolo POP rappresenta un’alternativa concreta e funzionale agli AirTag di Apple, con il vantaggio di essere compatibile anche con dispositivi Android e di offrire un livello di volume tra i più alti della categoria. Un’opzione interessante per chi cerca efficienza, versatilità e un tocco di personalizzazione nella gestione degli oggetti quotidiani.