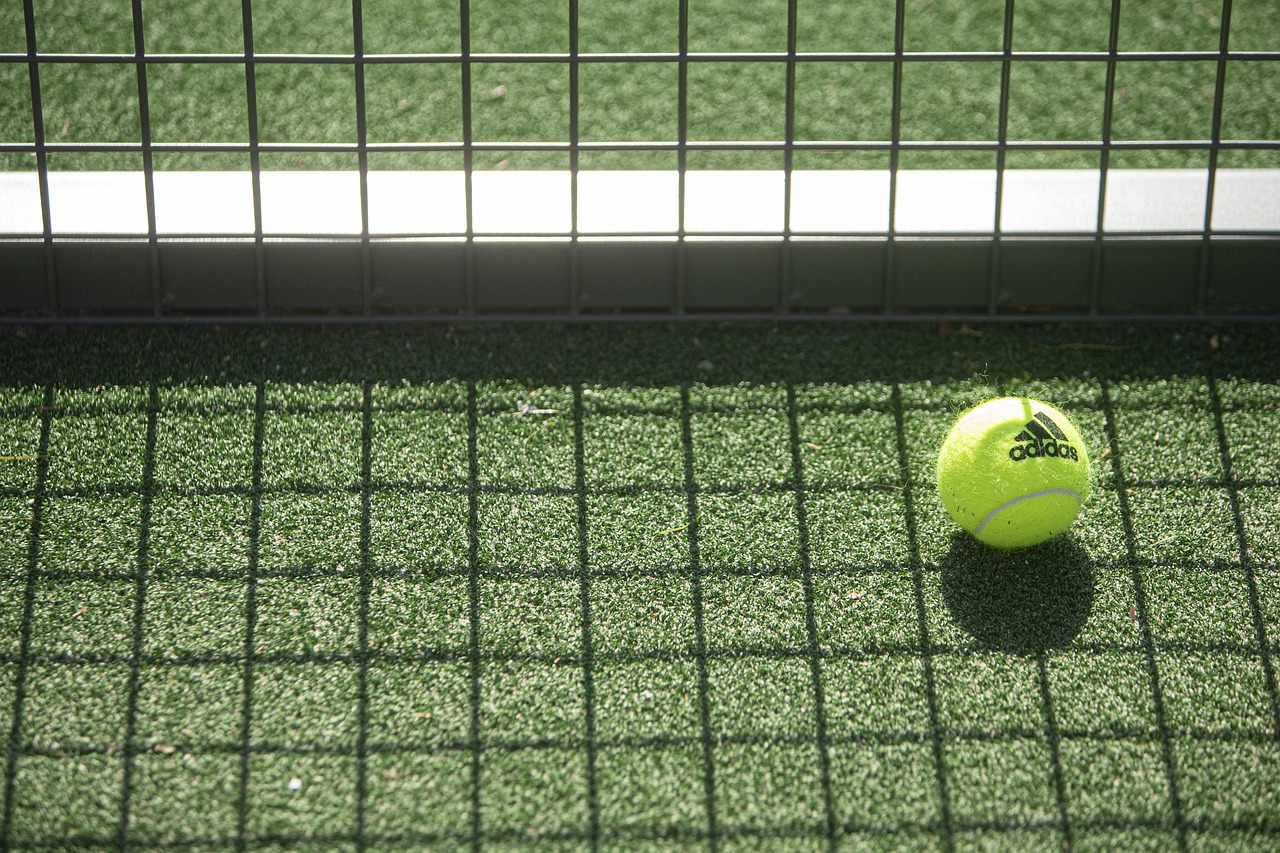Pixel Watch 4: prime indiscrezioni svelano grandi ambizioni di Google per il 2025
Dopo una raffica di leak dettagliati sui futuri smartphone Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL e Pixel 10 Pro Fold, Google sembra pronta a svelare un altro dispositivo attesissimo nel corso dell’estate. Anche questo nuovo prodotto, ormai non più avvolto dal mistero, si appresta a fare il suo debutto accanto ai telefoni della prossima generazione.
Si tratta, naturalmente, del Pixel Watch 4, che viene oggi mostrato in tutto il suo splendore grazie a una delle fonti più affidabili nel mondo della tecnologia mobile. Proprio come i nuovi smartphone Pixel, anche questo smartwatch — il diretto concorrente dell’Apple Watch — potrà sembrare familiare a un primo sguardo, soprattutto per chi segue da vicino l’evoluzione del settore wearable. Tuttavia, un’osservazione più attenta rivela modifiche di rilievo rispetto al design del Pixel Watch 3.
Cosa cambia davvero rispetto al modello precedente
Una delle differenze più evidenti riguarda lo spessore del dispositivo. Secondo le prime informazioni, il Pixel Watch 4 dovrebbe passare dai 12,3 mm del modello attuale a ben 14,3 mm. Un incremento notevole, che potrebbe non piacere a chi predilige un design più sottile ed elegante.
Il dato è ancor più sorprendente se si considera che sia il Pixel Watch originale del 2022 che il suo successore del 2023 avevano mantenuto esattamente lo stesso spessore di 12,3 mm. Confrontando questo valore con i 9,7 mm del Samsung Galaxy Watch 7 e dell’Apple Watch Series 10, il nuovo Pixel Watch rischia di sembrare meno competitivo sotto il profilo estetico e dell’ergonomia.
Scelte di design che faranno discutere
La decisione di aumentare lo spessore potrebbe essere legata a miglioramenti interni, come una batteria più capiente o nuove funzionalità hardware. Tuttavia, resta da vedere se questi vantaggi sapranno giustificare un design più massiccio, soprattutto in un mercato in cui l’equilibrio tra stile e funzionalità è sempre più importante.
Per gli utenti che pongono grande attenzione all’aspetto estetico di un orologio intelligente, questa novità potrebbe rappresentare un passo indietro. Al contrario, chi cerca potenza, nuove funzioni e magari una maggiore autonomia, potrebbe essere intrigato dalle scelte di Google.
Conclusioni in attesa della presentazione ufficiale
Il Pixel Watch 4 sembra destinato a seguire la strategia già adottata per i nuovi smartphone Pixel: evoluzione più che rivoluzione, ma con alcuni elementi distintivi che potrebbero fare la differenza. Resta ora da attendere la presentazione ufficiale per capire se le aspettative saranno soddisfatte — e se Google saprà davvero competere alla pari con i giganti del settore smartwatch.